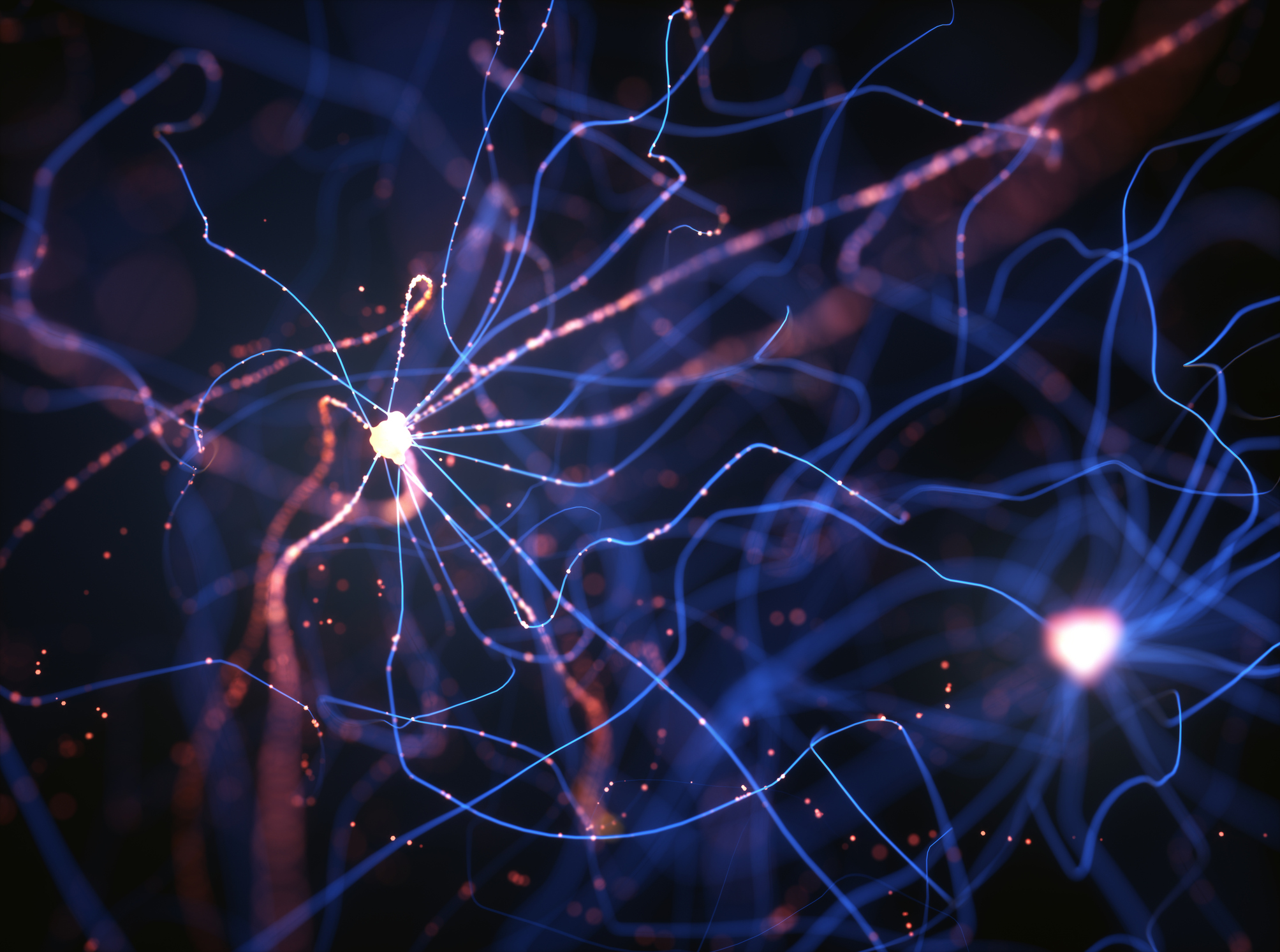Quanto è importante dormire, e dormire bene?
Cominciamo col dire questo: dorme chiunque abbia un cervello, dorme il moscerino come il verme, il polpo come la seppiolina. Bastano una manciata di neuroni. E dormire è fondamentale, tanto che il sonno viene preservato anche in condizioni estreme come nel caso di quegli animali che non possono permettersi di “fermarsi” a riposare.
Per i delfini, per esempio, che devono continuamente tornare in superficie per respirare, la natura ha escogitato l’incredibile strategia del sonno uni-emisferico. Dormono con l’emisfero destro per un’ora e mezza, poi è la volta dell’emisfero sinistro per l’altra ora e mezza. Lo stesso fanno molte specie di uccelli durante la migrazione. È incredibile, se ci fermiamo anche solo a pensarci.
Noi umani non ce lo potremmo permettere.
Che cosa succede quando si dorme poco o non si dorme affatto?
La deprivazione di sonno porta a gravi deficit cognitivi. È qualcosa di cui tutti abbiamo fatto esperienza dopo una notte in bianco. Ma se portiamo la condizione all’estremo, come nel caso dell’insonnia familiare fatale – una rara malattia che interferisce con il sonno e porta a un deterioramento della funzione mentale e a problemi di controllo dei movimenti – la mancanza di sonno diventa letale. Non si può vivere senza dormire, quando la veglia è troppo prolungata è a rischio la nostra stessa sopravvivenza.
Il sonno è regolato come tutti gli altri parametri vitali. Proprio come la pressione, l’equilibrio elettrolitico o la glicemia. Meno si dorme e più si attivano meccanismi che ci inducono a dormire. Più si dorme, più questi meccanismi si rilassano. E il sonno è fondamentale, è sempre stato fondamentale. Lo è per gli adulti come lo è anche di più per un cervello che si sta sviluppando.

©U.Ozel.Images (iStock).
È per questa ragione che è tanto importante il sonno di chi cresce? Come influisce sulla capacità di apprendimento e, quindi, quanto è importante dormire bene per imparare?
Il sonno è legato alla plasticità del cervello. Avere un cervello plastico – in grado di imparare e comprendere tutto quel che succede dal momento in cui si esce dalla pancia della madre e ci si confronta con il mondo – vuol dire poter fare affidamento su un organo estremamente elastico, in grado di modificarsi, adattarsi. È un organo che cambia strutturalmente: al microscopio elettronico il cervello di un neonato è molto diverso da quello di un bambino di un anno, che a sua volta è assai diverso da quello di un bambino di otto-nove anni, che è ancora profondamente differente dal cervello di un adolescente.
Tutti questi cambiamenti strutturali, che chiamiamo “plasticità” e che tipicamente avvengono quando interagiamo con il mondo durante la veglia, dal punto di vista fisiologico corrispondono a un aumento (o più spesso una selezione) delle connessioni neuronali. Alcune si fanno più forti, altre più deboli. È un processo che, perché avvenga in modo compiuto e ordinato, richiede un periodo in cui il cervello si stacchi e vada offline. Si dice che il sonno sia il prezzo che paghiamo per avere un cervello plastico. E chi ha il cervello più plastico è chi si sta incamminando nei primi passi della vita.
Lei dice: se dormiamo è perché c’è una buona ragione per farlo. Qual è? Serve a sedimentare, memorizzare, elaborare quanto si è vissuto, appreso in una giornata?
La ragione per cui, noi, dormiamo è un mistero irrisolto della biologia. Il sonno costituisce un terzo della vita di un essere umano, ma in effetti non è immediato comprenderne la funzione. Considerando la regolazione omeostatica del sonno possiamo dire che si tratta di un fenomeno fondamentalmente cerebrale, elettrico: dormire vuol dire avere un cervello percorso da onde lente che spazzano il cervello come fa il mare sul bagnasciuga.
C’è chi ha ipotizzato che il sonno sia una risposta a qualcosa che si accumula durante la veglia e che va periodicamente dissipato, come i radicali liberi. O che la veglia consumi risorse che ciclicamente devono essere reintegrate, come il glicogeno. Ma non esistono evidenze scientifiche in tal senso.
C’è chi pensa che il sonno abbia un ruolo nel consolidare le memorie. Una tesi che prende le mosse da un forte postulato: quando impariamo a fare qualcosa di nuovo, dopo una prima fase di rodaggio e acquisizione delle competenze, fare un sonnellino aumenta sistematicamente la nostra performance del 20 percento. Si è dunque ipotizzato che il sonno serva a ripercorrere e consolidare le esperienze. Anche in questo caso, però, non abbiamo riscontri oggettivi: l’attività elettrica del sonno è troppo diversa da quella della veglia.
Un terzo filone di ricerca mette insieme le due precedenti ipotesi e fornisce una spiegazione plausibile che, oggi, sta avendo molti riscontri sperimentali. L’idea è questa: il nostro cervello è un organo in continua costruzione che alla fine di ogni singola giornata accumula una quantità di informazioni molto eterogenee, “scritte” sotto forma di potenziamento sinaptico. Quando le connessioni tra i neuroni diventano più grosse e solide, occupano più spazio. E sono anche costose da un punto di vista energetico – il cervello corrisponde al 5 percento del peso corporeo ma consuma il 20 percento dell’energia a disposizione.
Ora, il cranio ha spazi e risorse energetiche limitati. Nel sonno il cervello si mette offline e ripulisce le informazioni raccolte dal rumore in eccesso, così che il sistema sia sostenibile e sempre più adatto all’ambiente in cui dovrà lavorare al risveglio.
È un’ipotesi, quest’ultima, che oggi sta ricevendo i maggiori consensi e che è nata nel gruppo di ricerca cui negli anni ho lavorato a lungo, di cui fanno parte Giulio Tononi e Chiara Cirelli.
Ha detto che il sonno è il prezzo che paghiamo per avere un cervello plastico. Perché?
Dormire è fondamentale, tanto che il sonno viene preservato anche in condizioni estreme come nel caso di quegli animali che non possono permettersi di “fermarsi” a riposare.
Come cambiano le abitudini al sonno durante la vita di un individuo?
Ci sono due aspetti da tenere in considerazione. Uno ha a che fare con quanto appena detto: se dormire è un prezzo alto da pagare, è bene attrezzarsi alla cosa. E in effetti sembra che per la nostra specie sia più naturale dormire in gruppo. Lo facciamo se è il nostro gruppo, la nostra famiglia, la nostra comunità. Ma c’è una ragione per questo. È noto, per esempio, che la popolazione mondiale è divisa 50 e 50 fra gufi e allodole, fra individui che amano tirare tardi e altri che sono mattinieri. Ha senso che l’evoluzione abbia selezionato un meccanismo per cui metà della tribù sta sveglia la prima parte della notte a fare la guardia per poi andare a letto quando l’altra metà è sveglia e attiva fin dalle prime ore del giorno.
C’è poi da considerare l’età e lo stile di vita che ciascuno sceglie o che tocca a ciascun individuo. Quello che la vita ci porta.
Ci hanno insegnato che chi dorme non piglia pesci. È proprio così?
Marcello Massimini
Marcello Massimini, medico e neurofisiologo, è ordinario presso l’Università degli Studi di Milano e invited professor presso il Coma Science Group dell’Università di Liegi. In Italia sta sviluppando nuovi strumenti per lo studio del sonno, della coscienza e delle sue alterazioni.