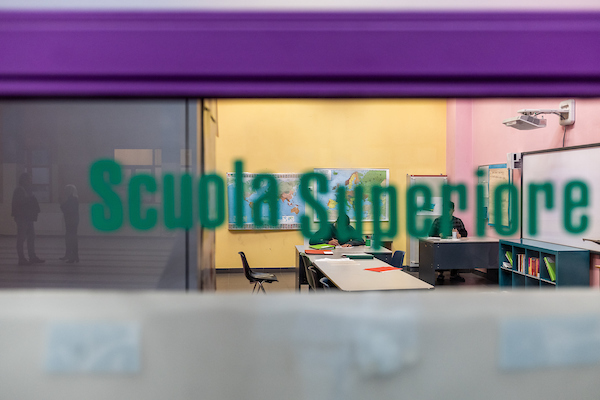Dove insegna? In quale contesto si trova la sua scuola?
Da quanto tempo insegna? E quali materie?
Ormai sono ventiquattro anni. I primi undici ho lavorato in una scuola paritaria di Napoli. Poi sono entrato nella scuola statale e mi sono trasferito qui in Umbria. Attualmente insegno matematica, scienze e tecnologia, ma il mio lavoro non si limita all’insegnamento curricolare: per molti anni ho tenuto laboratori di teatro, per questo, quando nella scuola organizzano sessioni di lettura ad alta voce, chiamano me.
In questa scuola cerco di realizzare una didattica senza un preciso limite delle discipline: gli insegnanti sono particolarmente selezionati e motivati, per cui riusciamo ad avere una vera apertura e comunicazione tra tutte le classi.
Come è arrivato all’insegnamento?
Ho lavorato per anni in una fabbrica a Palermo, sono un perito tecnico elettronico. Grazie a mia nonna ho coltivato da sempre una grande passione per la lettura. Mi piaceva anche la fotografia e ho iniziato a fare volontariato insegnandola ai bambini di un difficile quartiere palermitano. Lì è nato il mio profondo rapporto con i più piccoli.
Poi mi sono ritrovato a lavorare con persone fantastiche, tra cui Fiammetta Borsellino, la figlia di Paolo, e ho cominciato a fare fotografie per le riviste che si battevano contro la mafia. Quando Borsellino è stato ucciso, ho deciso di diventare maestro perché era l’unico contributo politico che mi sentivo di poter dare. Mi sono quindi messo a studiare per fare gli esami da esterno, mi sono diplomato e ho fatto il concorso per entrare nella scuola. Sono felice di aver fatto questa scelta, perché con i bimbi sto molto meglio che con gli adulti.
Quale didattica utilizza in classe?
In questi anni ha visto trasformazioni nella scuola?
I bambini che lavorano con me sono felici, entrano in un mondo di curiosità e di esplorazione perché si appropriano degli strumenti logici ponendosi dei problemi: non sono io che spiego, ci arrivano loro ragionando.
La formazione oggi offre un supporto agli insegnanti?
Giuseppe Pontremoli ha raccontato in un articolo un aneddoto illuminante: un giorno ha seguito un corso di formazione in cui gli insegnanti erano tutti seduti sui banchi mentre veniva loro spiegato quanto fosse importante il movimento del corpo. Ecco qui la contraddizione: perché me lo spieghi e non me lo fai provare?
La formazione prevalentemente frontale non permette agli insegnanti di mettersi in discussione, che è esattamente il nucleo centrale dell’insegnamento: tu devi essere capace di metterti in gioco sulla base della situazione concreta che ti trovi ad affrontare. Io arrivo in classe con un’idea magnifica, con il lavoro già preparato, poi un bambino alza la mano e propone qualcosa di inaspettato e geniale, un’idea migliore della mia. Io a quel punto cambio la lezione, mi adeguo. In questo modo i bambini imparano a credere in se stessi e nelle proprie possibilità
Quale ritiene che sia l’aspetto più interessante del suo lavoro?
Quali sono invece le difficoltà che incontra?
Quali sono gli ostacoli a un buon insegnamento?
Sicuramente è la paura di affrontare contrasti con colleghi o con dirigenti che la pensano diversamente da te. Quando sono arrivato nella mia scuola c’era una coordinatrice che aveva creato un rigido sistema di potere in cui non era concesso spazio per esprimere il proprio pensiero. Non esistevano momenti di discussione che permettessero di condividere dubbi e idee. Per fare un buon lavoro dev’esserci cooperazione e una ricerca comune per trovare insieme gli strumenti migliori.
Inoltre esiste il problema della rigida osservanza del programma: sembra che l’unica cosa che interessa molti insegnanti sia questo. C’è poco coraggio ad aprirsi, a mettersi in gioco e rischiare. C’è una chiusura difensiva perché nel momento stesso in cui dai la parola ai bambini quelli ti fanno delle domande alle quali a volte è difficile rispondere. E allora l’atteggiamento giusto sarebbe: “Non te lo so dire, però proviamo a vedere se riusciamo a scoprirlo”. Questo penso sia lo spirito corretto: fare in modo che la conoscenza sia al servizio del raggiungimento di altre conoscenze, in modo che il bambino sviluppi in sé capacità che gli permettano di imparare in modo autonomo.
Crede che un insegnante possa fare la differenza per i suoi studenti?
A Napoli ho incontrato un ragazzo che mi ha riconosciuto e abbracciato. Mi ha detto che mi aveva dedicato la tesi di astronomia. Ne ho incontrato un altro che era stato un mio alunno, geniale ma del tutto indisciplinato: è diventato un ingegnere aerospaziale. Quindi la risposta è sì. Al di là di questi casi eccezionali, mi sono sempre arrivate testimonianze da bambini ed ex bambini con i quali ho fatto un percorso: quello che vedo, che sento in maniera quasi tangibile, è che loro amano moltissimo quello che abbiamo fatto insieme.