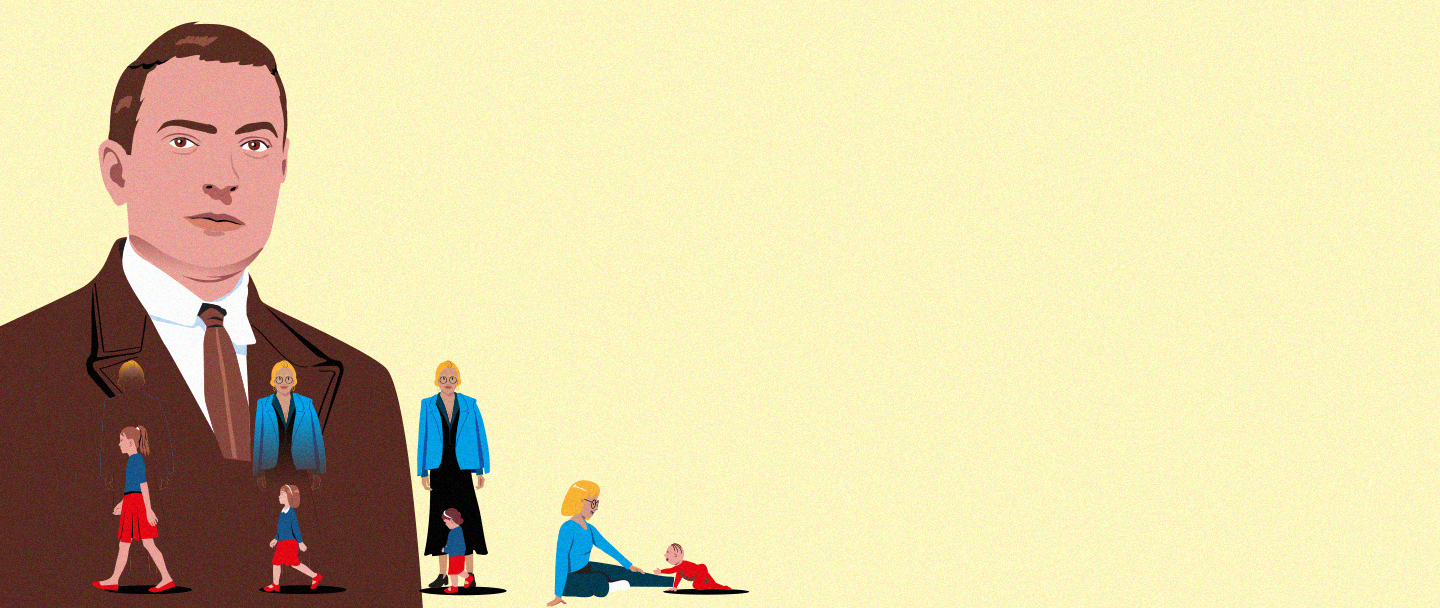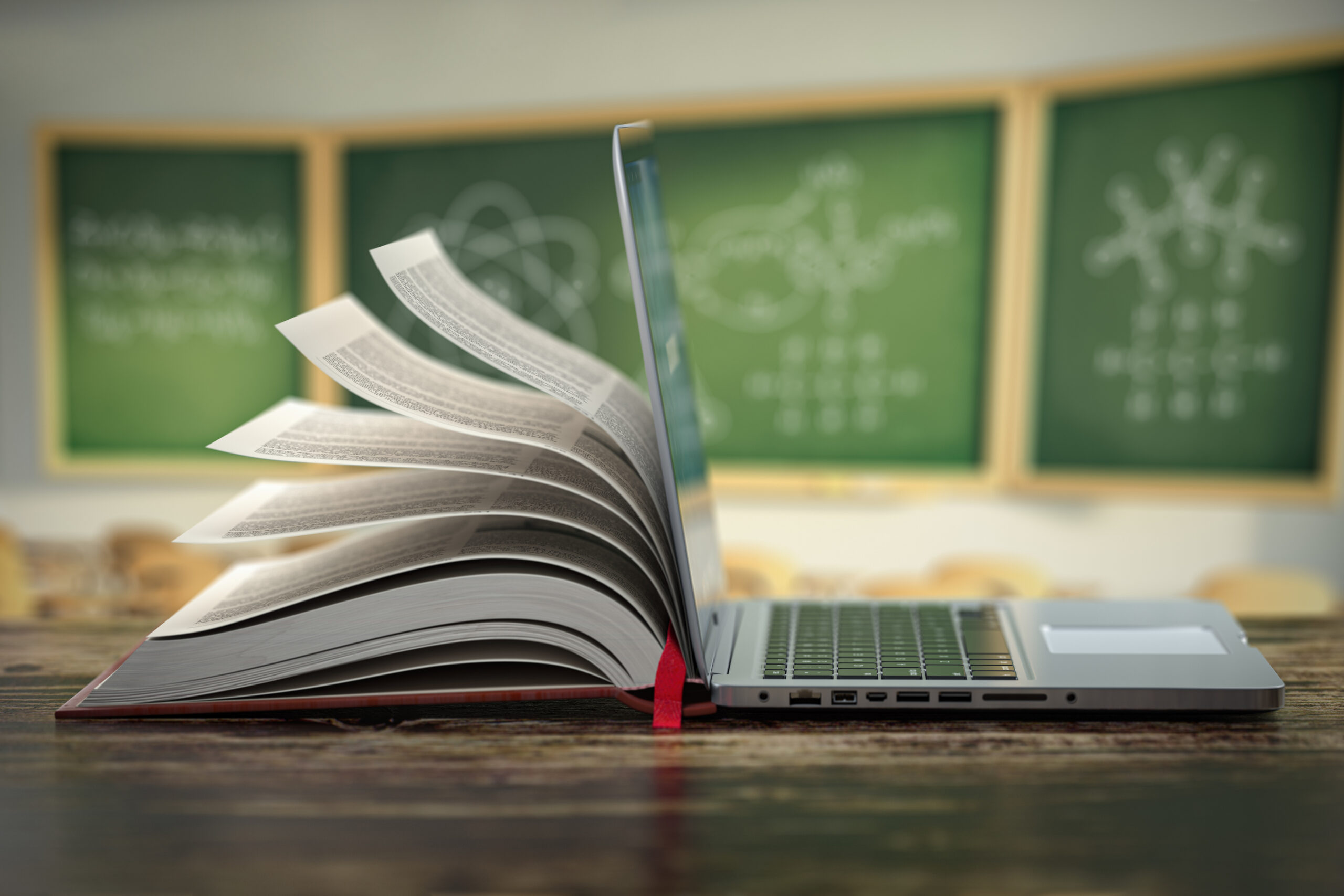John Dewey (Burlington, 20 ottobre 1859-New York, 1º giugno 1952) è stato uno fra i più importanti filosofi statunitensi vissuti fra Otto e Novecento. Il suo pensiero ha fortemente influenzato il dibattito culturale ed educativo non solo del suo tempo. Dewey infatti continua a essere un punto di riferimento ineludibile della riflessione pedagogica, anche per andare “oltre di lui”, come ebbe a scrivere Jerome Bruner in alcuni importanti saggi degli anni Sessanta.
In Italia furono principalmente la scuola di Firenze e Lamberto Borghi a introdurlo fra i giovani insegnanti avidi di un sapere che non fosse inquinato dal fascismo. Dewey, fra i primi ad affiancare la parola scuola con la parola democrazia, sembrò a molti un punto di riferimento ineludibile.
John Dewey è fra i pensatori che più hanno contribuito allo sviluppo del pragmatismo, una corrente di pensiero che nasce anche per dare risposte concrete ai problemi nuovi e laceranti che la società americana vive dopo la Guerra civile e con l’inizio dell’industrializzazione.
Fra le domande più rilevanti ce n’è una che Dewey non smetterà mai di indagare: come rendere più salda, più efficace, più giusta, la democrazia. Bastano le leggi oppure è indispensabile che i cittadini aderiscano spontaneamente alla prassi democratica?
Per rispondere a questa domanda, Dewey passa attraverso la riflessione su come funziona il pensiero e, dunque, l’apprendimento. Fin dal 1891 Dewey aveva iniziato a teorizzare su quanto di pedagogicamente rilevante vi fosse nel trattare il pensiero come un elemento dinamico. I pensieri, i concetti, non sono puri fatti mentali ma si costruiscono a partire dalla conoscenza della genesi, dei rapporti, fra i fatti stessi. Un’indicazione importante in un’epoca nella quale il problema dell’educazione di gruppi sempre più larghi di individui era strettamente legato al consolidarsi della democrazia. «Imparare a fare conoscendo e imparare a conoscere facendo.»
L’esperienza dunque, non più considerata come particolare, ma come qualcosa che essendo “gravido di nessi” diventa parte costitutiva del farsi del pensiero. Come scrive Lamberto Borghi:
L’esperienza è pertanto per il Dewey l’interazione fra l’individuo e il suo ambiente, un composto di passione e di azione, di un nostro subire l’ambiente e di un nostro reagire ad esso; e questo subire e reagire è un apportare modificazioni al dato per creare una nuova situazione, in un atteggiamento volto verso il futuro e non verso il passato.
La scuola può in questo senso agire in modo concreto sulla formazione di personalità democratiche attraverso un metodo che risulta essere attivo e progressivo.
L’esperienza diventa un affare del mondo. L’educazione uno sguardo rivolto verso ciò che ancora non è e non verso ciò che è già stato. La democrazia diventa il terreno di azione perfetto per questa idea pedagogica poiché perennemente in crisi e costantemente votata al cambiamento.
Ora prendiamo tutto questo e portiamolo dentro la scuola dell’obbligo e di massa dell’Italia del dopoguerra, e capiremo quanto per tanti e tante insegnanti Dewey sia stato prezioso per uscire dalle secche di un modello pedagogico astratto e di una fiducia assoluta nella capacità del maestro di modificare le menti dei suoi allievi.
Come ha scritto Luciana Bellatalla, la lettura di Dewey ha significato
Sottolineare i temi della coincidenza tra educazione e vita, della democrazia, della valenza etica e politica (e perciò umana e umanistica, se questi due termini possono essere concessi) dell’atto educativo, il learning by doing. Non è difficile rinvenire in questi temi il Leitmotiv di tutto l’attivismo laico del secondo dopoguerra italiano: i cosiddetti maestri popolari – da Bernardini a Lodi – hanno condiviso questa cornice “teorica”, l’hanno tradotta in viva pratica quotidiana, mescolando Dewey e Freinet o, talora. addirittura lasciando Dewey sullo sfondo e affidandosi in tutto alle tecniche freinetiane.
Per questo, ancora oggi, in modo più o meno consapevole, l’influenza di John Dewey continua a essere molto più presente di quanto ci aspetteremmo.