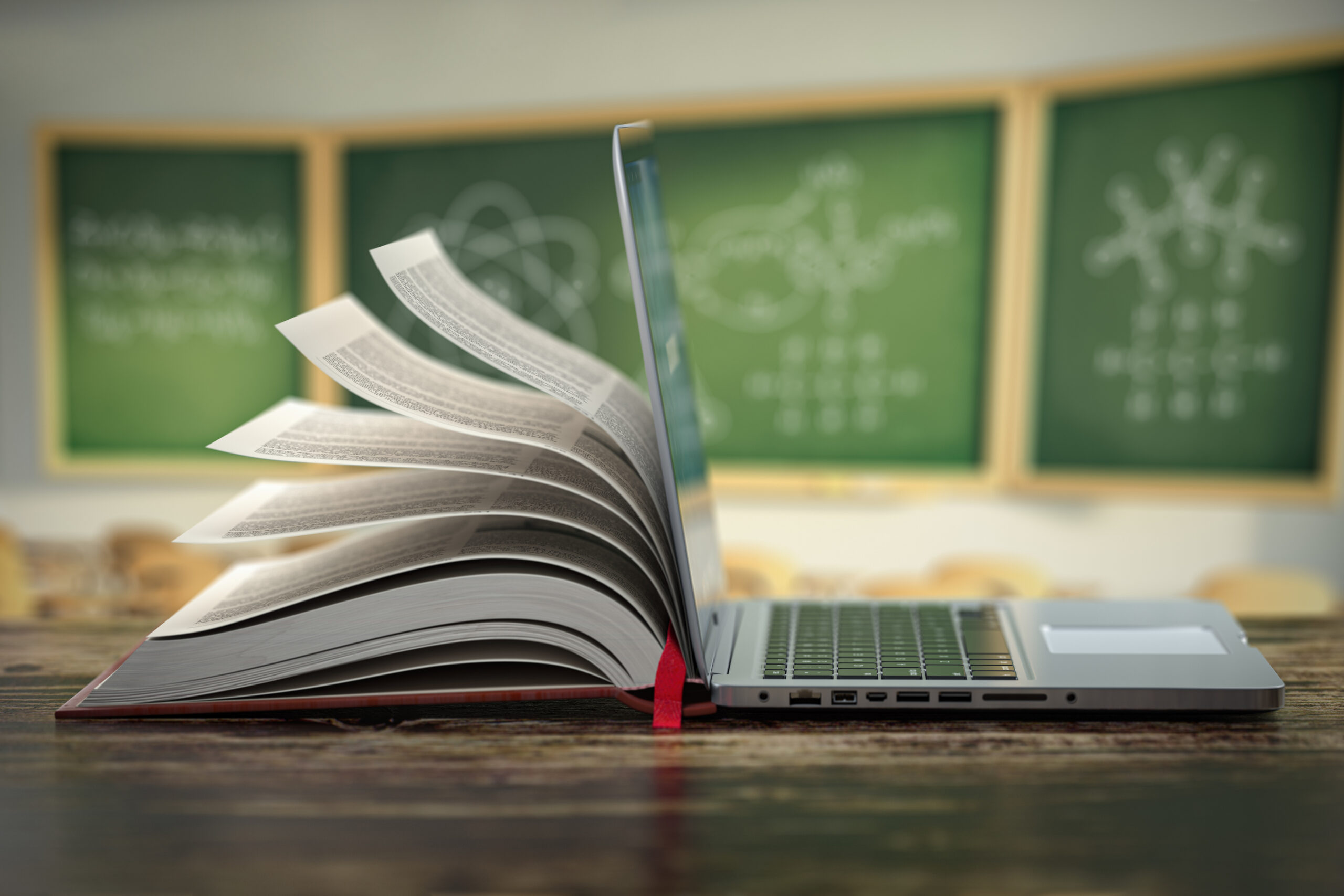Secondo Vygotskij:
Dopo gli studi universitari in giurisprudenza a Mosca, Vygotskij tornò a Gomel’, dove insegnò presso la scuola magistrale locale, organizzando corsi di specializzazione per maestri e coltivando la sua grande passione per la letteratura, anche attraverso la fondazione di una piccola casa editrice. In quegli anni si dedicò alla psicologia dell’educazione, distinguendosi ai convegni di pedagogia e accedendo all’insegnamento presso l’Istituto di Psicologia di Mosca, città in cui si trasferì di nuovo con la moglie Roza nel 1924. Le esperienze sul campo più importanti per lo sviluppo delle sue teorie furono il lavoro presso l’Istituto di Difettologia, dove si dedicò all’istruzione di bambini con disabilità fisiche e cognitive, e, nel 1929, la spedizione scientifica in Uzbekistan.
Il governo comunista assegnò infatti a Vygotskij e al collega Alexandr Lurija, brillanti esponenti delle avanguardie psicologiche, il compito di studiare il tessuto sociale uzbeko, un territorio prevalentemente agricolo con altissimi livelli di analfabetismo, per impostare un sistema educativo unitario, di stampo russo, che avrebbe favorito la coesione dell’Unione Sovietica, composta da molte lingue e culture.
In Uzbekistan, Vygotskij trovò conferma delle sue teorie sull’importanza del contesto socioculturale nell’apprendimento dei bambini che, cresciuti in un ambiente rurale, privo di scolarizzazione, ricevevano stimoli molto diversi rispetto ai coetanei che vivevano, ad esempio, nel centro di Mosca. I risultati dello studio non piacquero al governo sovietico: emergeva infatti la difficoltà di imporre dall’alto un sistema scolastico uniforme senza considerare le specificità dei vari territori.
Vygotskij è considerato il padre della scuola storico-culturale che sottolinea, appunto, l’importanza dei fattori storici, sociali e culturali nello sviluppo psicologico dell’individuo. Secondo il pedagogista, ogni bambino, nei primi anni di vita, acquisisce conoscenze e competenze grazie all’interazione con genitori, insegnanti e altre figure di riferimento. Esiste, per Vygotskij, una zona di sviluppo prossimale, lo spazio tra ciò che un bambino è in grado di fare autonomamente e ciò che può apprendere con l’aiuto di qualcuno di più esperto. Ad esempio, nel processo di apprendimento dell’alfabeto e della capacità di leggere è evidente come la stimolazione e il supporto forniti dall’adulto possano facilitare il progresso.
L’apprendimento, dunque, è mediato socialmente dall’ambiente umano che circonda il bambino. Questa idea fu successivamente elaborata dallo psicologo statunitense Jerome Bruner con il concetto di scaffolding (impalcatura), un’immagine che suggerisce come l’acquisizione di nuove conoscenze sia sostenuta da un sostegno costruito dall’adulto.
L’importanza attribuita ai fattori socioculturali e alla collaborazione con figure esperte, che oggi ci appare quasi ovvia, rappresentò all’epoca una rivoluzione. La pedagogia era infatti influenzata dagli studi di Jean Piaget, psicologo svizzero coetaneo di Vygotskij, il quale si concentrava sulla costruzione autonoma e individuale, da parte del bambino, del proprio percorso di apprendimento.
Un altro fondamentale contributo di Vygotskij riguarda il ruolo del linguaggio nello sviluppo del pensiero. Nel suo libro Pensiero e linguaggio, lo studioso russo osservò che i discorsi solitari che i bambini fanno con se stessi mentre svolgono un’azione favoriscono l’interiorizzazione di nuovi movimenti e abilità. Il linguaggio, quindi, non è solo un mezzo per esprimersi, ma il mediatore tra sé e il mondo, che permette di assimilare concetti e conoscenze in modo più veloce ed efficace. Pensiero e linguaggio sono legati da un rapporto circolare e indissolubile, influenzandosi e plasmandosi a vicenda.
Nel 1934 la tubercolosi, che lo affliggeva da anni, portò Vygotskij a una morte prematura. Intellettuale libero, fu osteggiato dal regime sovietico, che ne bandì le opere fino al 1956: non gli perdonò la vicinanza alla Società Psicoanalitica (la psicoanalisi fu osteggiata in epoca staliniana) e a dissidenti, come Pasternak o Mandel’štam, né le critiche mosse, in seguito alla spedizione uzbeka, al progetto di panrussificare il sistema educativo delle repubbliche sovietiche. Commentando la recente pubblicazione dei Taccuini di Vygotskij, Luciano Mecacci, uno dei suoi più noti studiosi italiani, nota: